|
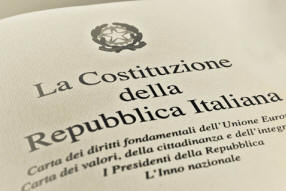 “La letteratura è volta all’illegalità”. Pausa.
Siamo troppo abituati ai clichè tradizionalisti
che la frase ci sconvolge. L’inchiostro sulla
carta prende forma e misura di reato. La poesia
non fa ordine e realtà come la legge. Ricerca la
verità ma non pretende di essere evidente.
De-razionalizza, personalizza, codifica le
esistenze attraverso il linguaggio delle
emozioni. Ripristina le parole nella coscienza
delle lettere. Diviene ricerca di mancanze,
trasgressione de facto ai limiti imposti de
iure. L’antitesi (apparente) dell’accezione del
diritto: esercizio della forza attraverso la
legittimità, l’estetica delle cose, la
disciplina dell’esteriorità di Russell, la “x”
di Kelsen a fondamento del giuspositivismo
sociale e razionale. Il rapporto tra diritto e
letteratura è complesso ed intricato, una
matassa di fili che si spezzano e riallacciano.
Ubi societas ibi ius. Nasce l’interpretazione,
l’accettazione giuridica di norme
comportamentali all’interno di organi statali,
il dover essere kantiano si uniforma al
legiferare dell’ordinamento positivo. È la prima
forma di “sussunzione” delle sfere particolari
sotto l’universale: la morale (prima astrazione
intellettuale e deontologicamente imperfetta) si
concretizza nelle tutela delle relazioni
sociali. Il triangolo letteratura-diritto,
diritto-letteratura si completa. E la
Costituzione si rivela l’esplicazione più
evidente. “La letteratura è volta all’illegalità”. Pausa.
Siamo troppo abituati ai clichè tradizionalisti
che la frase ci sconvolge. L’inchiostro sulla
carta prende forma e misura di reato. La poesia
non fa ordine e realtà come la legge. Ricerca la
verità ma non pretende di essere evidente.
De-razionalizza, personalizza, codifica le
esistenze attraverso il linguaggio delle
emozioni. Ripristina le parole nella coscienza
delle lettere. Diviene ricerca di mancanze,
trasgressione de facto ai limiti imposti de
iure. L’antitesi (apparente) dell’accezione del
diritto: esercizio della forza attraverso la
legittimità, l’estetica delle cose, la
disciplina dell’esteriorità di Russell, la “x”
di Kelsen a fondamento del giuspositivismo
sociale e razionale. Il rapporto tra diritto e
letteratura è complesso ed intricato, una
matassa di fili che si spezzano e riallacciano.
Ubi societas ibi ius. Nasce l’interpretazione,
l’accettazione giuridica di norme
comportamentali all’interno di organi statali,
il dover essere kantiano si uniforma al
legiferare dell’ordinamento positivo. È la prima
forma di “sussunzione” delle sfere particolari
sotto l’universale: la morale (prima astrazione
intellettuale e deontologicamente imperfetta) si
concretizza nelle tutela delle relazioni
sociali. Il triangolo letteratura-diritto,
diritto-letteratura si completa. E la
Costituzione si rivela l’esplicazione più
evidente.
All’assemblea di Istituto del Telesi@,
interviene Felice Casucci , professore ordinario
alla facoltà di Diritto Comparato, Docente di
“Diritto e Letteratura” e Direttore del “Centro
Studi di Diritto Comunitario”, presso
l’Università degli Studi del Sannio. Tema della
trattazione la Costituzione Italiana, un
excursus giuridico ed inter-disciplinare, dalla
poesia confessionale (in ricordo di Sylvia Plath)
al rapporto tra diritto e letteratura in
P.Grossi e De Amicis (“La civiltà di un popolo
si vede nel modo in cui sta in strada” – libro
Cuore) passando per gli appunti della
Costituente di Pietro Calamandrei e il moderno
(nuovo) Umanesimo giuridico.
-E che cos’è?- Verrebbe da chiedersi. Il
concetto di “Umanesimo giuridico” è
indissolubilmente legato al relativismo della
democrazia ed all’assenza di dogmatismo etico
(dove per etica si intende l’agire misurato).
Non esistono valori assoluti, certezze
storicamente inconfutabili, principi di
astrazione universale. Il diritto romano è tanto
valido quanto lo sono i diritti nazionali. Lo
ius è calato nel reale (per dirla con De Sanctis.
È l’essenza della società nei pantaloni del
presente, la concretizzazione delle
manifestazioni umane nella quotidianità, che
inevitabilmente ci riguarda e condiziona. Un po’
il giudice democratico di B.Brecht,
l’uguaglianza sostanziale oltre (e dentro)
quella formale, la prosa dei colori e delle
sfumature contro l’aridità scientifica (la
trasformazione graduale di Calamandrei). Il
diritto alla diversità. È quindi lo Stato che
forma il cittadino o il cittadino che fonda lo
Stato? Esistono dei diritti naturali presenti a
priori o è il giuspositivismo stesso a
riconoscere e poi fondare il patrimonio
“inviolabile” dell’uomo? Da un lato le
“statolatrie” di Hobbes, Rousseau ed Hegel,
dall’altro l’individualismo positivo di
Tocqueville, Stirner e l’oltre-moralità di
Nietzsche. Il legiferare ossessivo della
Modernità, teso ad invadere ogni aspetto sociale
e relazionale del reale, può offuscare i valori
e il significato della morale emotivamente
intesa? È la stessa domanda che si pone
Zagrebelsky nel suo “Intorno alla legge” ed è lo
stesso spunto di riflessione che vogliamo
comunicarvi. Nella speranza che, prima o poi,
Antigone batta Creonte.
Alleghiamo alcuni passi del discorso di Pietro
Calamandrei pronunciato nel salone degli
Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio
1955 e rivolto principalmente ai giovani. In un
tempo di instabilità politica, economica e
sociale, La Costituzione Italiana è la base
della rivoluzione culturale che ci attende. Base
del diritto e fondamento delle leggi positive,
sintesi di letteratura e pragmaticità, diritti
e doveri (che non possono essere scelti o
abbandonati per abnegazione di responsabilità),
riscoperta del significato di essere persona. Le
conquiste della Storia e i sacrifici del passato
hanno l’obbligo di essere difesi e rispettati.
Applicati, realizzati, non venduti. Esistono
altre forme di dissenso, violare i propri
compiti è mancanza di impegno e solidità. È il
diritto che nasce dal dovere e non viceversa.
Devo quindi posso. Oltre l’apatia ideologica e
sociale, al di là dell’indifferentismo
generazionale, per semplice, limpida e chiara
onestà intellettuale. La democrazia non richiede
niente a nessuno, ma ha bisogno molto da tutti.
Anche quando non sentirsi cittadini sarebbe
molto più facile. E conveniente.
“Però, vedete, la costituzione non è una
macchina che una volta messa in moto va avanti
da sé. La costituzione è un pezzo di carta: la
lascio cadere e non si muove. Perché si muova
bisogna ogni giorno rimetterci dentro il
combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno,
lo spirito, la volontà di mantenere queste
promesse, la propria responsabilità. Per questo
una delle offese che si fanno alla costituzione
è l’indifferenza alla politica,
l’indifferentismo politico che è -non qui, per
fortuna, in questo uditorio, ma spesso in larghe
categorie di giovani- una malattia dei giovani.
“La politica è una brutta cosa”, “che me ne
importa della politica”: quando sento fare
questo discorso, mi viene sempre in mente quella
vecchia storiella, che qualcheduno di voi
conoscerà, di quei due emigranti, due contadini,
che traversavano l’oceano su un piroscafo
traballante. Uno di questi contadini dormiva
nella stiva e l’altro stava sul ponte e si
accorgeva che c’era una gran burrasca con delle
onde altissime e il piroscafo oscillava: E
allora questo contadino impaurito domanda a un
marinaio: “Ma siamo in pericolo?”, e questo
dice: “Se continua questo mare, il bastimento
fra mezz’ora affonda”. Allora lui corre nella
stiva svegliare il compagno e dice: “Beppe,
Beppe, Beppe, se continua questo mare, il
bastimento fra mezz’ora affonda!”. Quello dice:
” Che me ne importa, non è mica mio!”. Questo è
l’indifferentismo alla politica. E’ così bello,
è così comodo: la libertà c’è. Si vive in regime
di libertà, c’è altre cose da fare che
interessarsi alla politica. E lo so anch’io! Il
mondo è così bello, ci sono tante cose belle da
vedere, da godere, oltre che occuparsi di
politica. La politica non è una piacevole cosa.
Però la libertà è come l’aria: ci si accorge di
quanto vale quando comincia a mancare, quando si
sente quel senso di asfissia che gli uomini
della mia generazione hanno sentito per
vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di
non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai
a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi
auguro di riuscire a creare voi le condizioni
perché questo senso di angoscia non lo dobbiate
provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla
libertà bisogna vigilare, dando il proprio
contributo alla vita politica. La costituzione,
vedete, è l’affermazione scritta in questi
articoli, che dal punto di vista letterario non
sono belli, ma è l’affermazione solenne della
solidarietà sociale, della solidarietà umana,
della sorte comune, che se va a fondo, va a
fondo per tutti questo bastimento. E’ la carta
della propria libertà, la carta per ciascuno di
noi della propria dignità di uomo.
Ora vedete- io ho poco altro da dirvi-, in
questa costituzione, di cui sentirete fare il
commento nelle prossime conferenze, c’è dentro
tutta la nostra storia, tutto il nostro passato.
Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le
nostre glorie son tutti sfociati in questi
articoli. E a sapere intendere, dietro questi
articoli ci si sentono delle voci lontane.
Ma
ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto
sangue e quanto dolore per arrivare a questa
costituzione! Dietro a ogni articolo di questa
costituzione, o giovani, voi dovete vedere
giovani come voi, caduti combattendo, fucilati,
impiccati, torturati, morti di fame nei campi di
concentramento, morti in Russia, morti in
Africa, morti per le strade di Milano, per le
strade di Firenze, che hanno dato la vita perché
la libertà e la giustizia potessero essere
scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho
detto che questa è una carta morta, no, non è
una carta morta, questo è un testamento, un
testamento di centomila morti. Se voi volete
andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata
la nostra costituzione, andate nelle montagne
dove caddero i partigiani, nelle carceri dove
furono imprigionati, nei campi dove furono
impiccati. Dovunque è morto un italiano per
riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o
giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra
costituzione.”
Pietro Calamandrei. |